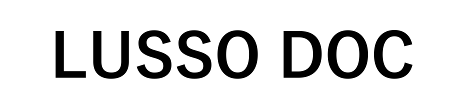MILANO
Uffici della CRITICA SOCIALE
Portici Galleria N. 23
— 1896
Feltrinelli Reprint
in collaborazione con la Biblioteca dell’Istituto G.G. Feltrinelli
Fotolito e stampa: “La Tipolito Milano-Roma”- Milano
AL LETTORE ITALIANO
Proemio di Federico Engels alla presente versione
La pubblicazione del Manifesto del Partito comunista coincidette, si può dire, colla giornata del 18 marzo 1848, colle rivoluzioni di Milano e di Berlino, che furono la levata di scudi delle due nazioni situate nel centro, l’una del continente europeo, l’altra del Mediterraneo; due nazioni fino allora infiacchite dalla divisione e dalle discordie intestine, e passate, per conseguenza, sotto il dominio straniero. Se l’Italia era soggetta all’imperatore d’Austria, la Germania subiva il giogo non meno effettivo, benchè più indiretto, dello czar di tutte le Russie. Le conseguenze del 18 marzo 1848 liberarono Italia e Germania da cotesta vergogna; se, dal 1848 al 1871, queste due grandi nazioni furono ricostituite e, in qualche modo, rese a se stesse, ciò avvenne, come diceva Carlo Marx, perchè gli uomini, che hanno abbattuta la rivoluzione del 1848, ne furono tuttavia, loro malgrado, gli esecutori testamentari.
Da per tutto, quella rivoluzione fu l’opera della classe operaia; fu questa che fece le barricate e pagò di persona. Soli gli operai di Parigi, rovesciando il Governo, avevano l’intenzione ben determinata di
rovesciare il regime della borghesia. Ma, per quanto essi avessero coscienza dell’antagonismo fatale che esisteva fra la loro propria classe e la borghesia; nè il progresso economico del paese, nè lo sviluppo intellettuale delle masse operaie francesi erano giunti al grado che avrebbe resa possibile una ricostruzione sociale. I frutti della rivoluzione furono dunque, in ultima analisi, raccolti dalla classe capitalista. Nelle altre nazioni, in Italia, in Germania, in Austria, gli operai non fecero, da principio, che portare al potere la borghesia. Ma in qualsiasi paese il regno della borghesia non è possibile senza l’indipendenza nazionale. La rivoluzione del 1848 doveva dunque trarsi dietro l’unità e l’autonomia delle nazioni che fino allora ne mancavano: l’Italia, la Germania, l’Ungheria. La Polonia seguirà alla sua volta. Se, dunque, la rivoluzione del 1848 non fu una rivoluzione socialista, essa spianò la via, preparò il terreno a quest’ultima. Collo slancio dato, in ogni paese, alla grande industria, il regime borghese di questi ultimi quarantacinque anni ha creato, dovunque, un proletariato numeroso, concentrato e forte; allevò dunque, per usare l’espressione del Manifesto, i suoi proprî seppellitori. Senza l’autonomia e l’unita restituite a ciascuna nazione, nè l’unione internazionale del proletariato, nè la tranquilla e intelligente cooperazione di coteste nazioni verso fini comuni potrebbero compiersi. Immaginate, se vi riesce, una azione internazionale comune degli operai italiani, ungheresi, tedeschi, polacchi, russi, nelle condizioni politiche
precedenti al 1848!
Così, le battaglie del 1848 non furono date indarno; del pari non passarono indarno i quarantacinque anni che ci separano da quella tappa rivoluzionaria. I frutti vengono a maturanza, e tutto ciò ch’io desidero è che la pubblicazione di questa versione italiana sia di buon augurio per la vittoria del proletariato italiano, quanto la pubblicazione dell’originale lo fu per la rivoluzione internazionale.
Il Manifesto rende piena giustizia all’azione rivoluzionaria che il capitalismo ebbe nel passato. La prima nazione capitalista è stata l’Italia. Il chiudersi del medioevo feudale, l’aprirsi dell’êra capitalista moderna sono contrassegnati da una figura colossale; è un italiano, il Dante, al tempo stesso l’ultimo poeta del medioevo e il primo poeta moderno. Oggidì, come nel 1300, una nuova êra storica si affaccia. L’Italia ci darà essa il nuovo Dante, che segni l’ora della nascita di questa nuova êra proletaria?
Londra, 1° febbraio 1893.
FEDERICO ENGELS.
NOTA A QUESTA SECONDA EDIZIONE ITALIANA
L’augurio che Federico Engels indirizzava, nel proemio, al proletariato italiano è in via di compiersi, e così rapidamente che si può notarlo già a distanza di poco più di due anni. Invero questi due anni furono fecondi per lo sviluppo del socialismo scientifico in Italia quanto forse non lo era stato alcuno dei decenni precedenti. Il breve tempo, che fu necessario ad esaurire la prima edizione italiana del Manifesto, esaurì del pari molte altre cose nell’ordine dei fatti e, di riflesso, in quello del pensiero, che all’apparire di essa sembravano ancora abbastanza salde in Italia. Gli scandali politico- bancarii, la dittatura di Francesco Crispi, l’abolizione di fatto dello Statuto del regno, le leggi eccezionali, la persecuzione delle idee spinta a limiti d’ipocrisia, di servilità e di ferocia non toccati forse da verun altro Stato europeo, la restrizione fraudolenta del diritto elettorale (che radiò d’un colpo un milione d’elettori in un paese ove il suffragio era già ristrettissimo, riducendo la media degli elettori dal 9,67 al 6,86 % sulla popolazione, e in alcune provincie del mezzodì al 3 e al 2,87 %); tutti questi fatti correlativi fra loro, che si spiegano e si suppongono a vicenda, mentre, da un lato,
denudarono il vero carattere della rivoluzione borghese italiana e stabilirono la impotenza delle nostre classi dominanti a reggere lo Stato colle forme della libertà e con metodi civili; dall’altro lato, educarono a coltura intensiva (se così può dirsi) la neonata coscienza di classe del proletariato italiano. L’antica idealità di patria, superante e dissimulante il conflitto delle classi, esaltava grottescamente i suoi ultimi rantoli nella commedia testè recitatasi, impresario il Governo, delle feste giubilari del 20 settembre, cui partecipavano, come di ragione, tutti i saccheggiatori di Banche, i pubblici mantenuti, gli africanisti governativi e i ladri di pubblici demanii, mentre se ne appartava, con sdegnose proteste, il proletariato cosciente d’ogni parte della penisola. Questo, invece, misurava le proprie forze nelle recenti elezioni generali, o su propri condannati liberi, o sul nome dei condannati politici, e le trovava quasi triplicate appena in un triennio, malgrado le castrazioni già accennate delle liste elettorali e ogni sorta di minaccie e di persecuzioni.
Ben può dirsi, così, che la prima edizione del Manifesto comunista comparve in Italia alla sua ora: e a noi è debito, quella esaurita, allestirne subito un’altra, doppia di esemplari, per le crescenti richieste. Non solo le file dei socialisti si raddoppiano di anno in anno, quanto più si suda dalle polizie per falcidiarle e per disperderle, ma ne cresce la compattezza in ragione degli scioglimenti, e lo slancio e la convinzione che le anima quanto più tribunali e commissioni statarie
distribuiscono prodigalmente agli adepti reclusione, confino e domicilio coatto. La dottrina del Manifesto penetra di più in più le coscienze, di più in più colora di sè le manifestazioni del partito, sospinge nelle ultime trincee il vecchio socialismo impuro e sentimentale dei metafisici e degli opportunisti, ed è argomento a discussioni e studî, fra i quali notevolissimo quello del prof. Antonio Labriola (In memoria del Manifesto dei comunisti: saggio sulla concezione materialistica della storia), che anch’esso, uscito nell’estate del 1895, è già alla sua 2.a edizione in pochi mesi.
Un solo rammarico ci turba nel dar fuori questa nuova edizione: non poterne fare omaggio a quello dei due autori che visse più a lungo e che fu, in questi primi anni della vita del partito in Italia, il nostro affettuoso consigliere ed amico. Federico Engels morì appunto in quest’anno, e fu lutto, non di una nazione, ma del proletariato militante del monda intero. Di lui, degli aiuti che ci porse, della sua comunione di pensiero con Marx dicemmo nell’Introduzione al suo schizzo giovanile L’Economia politica, pubblicato appunto in occasione della sua morte. Ci conforta il pensiero ch’egli vide, prima di morire, anche l’Italia proletaria fare alfine atto di presenza sulla scena rivoluzionaria, entrare risolutamente in quell’arena sulla quale egli l’aveva con tanto affetto chiamata.
Novembre 1895.
GLI EDITORI.
PREFAZIONI
I.
La “Lega dei Comunisti”, associazione internazionale dei lavoratori, che per le condizioni d’allora naturalmente doveva essere segreta, nel Congresso tenuto a Londra in novembre 1847 incaricò i sottoscritti di stendere un particolareggiato programma teorico e pratico del partito. Così nacque il seguente Manifesto, il cui manoscritto fu inviato per la stampa a Londra poche settimane prima della rivoluzione di febbraio. Pubblicato dapprima in tedesco, ebbe in questa lingua almeno dodici diverse edizioni per la Germania, l’Inghilterra e l’America. In inglese apparve la prima volta nel 1850 a Londra nel Red Republican, tradotto da miss Elena Macfarlane, e nel 1871 in America con almeno tre diverse traduzioni. In francese poco prima della insurrezione del giugno 1848, e più di recente nel Socialiste di Nuova York, e se ne prepara un’altra traduzione. In polacco a Londra poco dopo la prima edizione tedesca. In russo a Ginevra dopo il sessanta. La versione danese seguì immediatamente la prima pubblicazione del Manifesto.
Benchè negli ultimi venticinque anni le circostanze si siano molto cambiate, i principî generali svolti nel
Manifesto conservano ancora nell’insieme la loro esattezza. Qualche parte dovrebbe essere qua e là ritoccata. L’applicazione pratica di questi principî, come spiega il Manifesto stesso, dipenderà in ogni luogo e in ogni tempo dalle condizioni storiche del momento; non si dia perciò troppo peso alle proposte rivoluzionarie che si leggono in fine al capo II. Oggi quel passo potrebbe essere diverso sotto varî rapporti. Di fronte all’enorme e rapido sviluppo della grande industria negli ultimi venticinque anni e all’organizzazione in partito della classe lavoratrice che è proceduta con pari rapidità, di fronte alle esperienze pratiche della rivoluzione di febbraio e, più ancora, della Comune di Parigi, dove il proletariato per la prima volta tenne per due mesi il potere politico, questo programma è certamente invecchiato. La Comune dimostrò che “non basta che la classe lavoratrice prenda possesso della macchina dello Stato qual è, per volgerla a’ proprî scopi”. (Vedi: La guerra civile in Francia, indirizzo del Consiglio generale dell’Associazione internazionale dei lavoratori, edizione tedesca, pag. 19, dove questo concetto è svolto più diffusamente). Anche la critica della letteratura socialista tedesca è certamente oggi incompleta, giungendo appena al 1847, e lo stesso dicasi delle osservazioni sull’atteggiamento dei comunisti di fronte ai diversi partiti di opposizione (capo IV); osservazioni le quali, sebbene ancor vere in linea generale, sono invecchiate nella possibilità delle loro applicazioni, per ciò solo che la situazione politica s’è
affatto trasformata e l’evoluzione storica soppresse la maggior parte dei partiti ivi enumerati.
Frattanto il Manifesto è un documento storico che non ci sentiamo più in diritto d’alterare. Forse in una edizione successiva potrà aggiungersi una introduzione che in qualche modo getti un ponte fra il 1847 ed oggi, ma questa ristampa ci giunge troppo improvvisa per lasciarcene tempo.
Londra, 24 giugno 1872.
CARLO MARX – FEDERICO ENGELS.
II.
Pur troppo debbo sottoscrivere io solo la prefazione, di quest’altra edizione. Marx, l’uomo a cui tutta la classe operaia di Europa e d’America deve più che ad alcun altro, Marx riposa nel cimitero di Highgate e già cresce la prima erba sulla sua tomba. Dopo la sua morte non si può più parlare di ritocchi e di aggiunte al Manifesto. Tanto più credo necessario di esplicitamente riaffermare quanto segue.
Il pensiero fondamentale cui s’informa il Manifesto: che la produzione economica, e il congegno sociale che in ciascuna epoca storica necessariamente ne deriva, è base della storia politica e intellettuale dell’epoca stessa; che conforme a ciò (dopo il dissolversi della primitiva
proprietà comune del suolo) tutta la storia fu storia di lotte di classi, lotta fra classi sfruttate e sfruttatrici, dominate e dominatrici, nei varî gradi dello sviluppo sociale; che questa lotta ha ormai raggiunto un grado in cui la classe sfruttata e oppressa (il proletariato) non può più liberarsi dalla classe che sfrutta e opprime (la borghesia) senza liberar insieme e per sempre dallo sfruttamento e dalla oppressione tutta la società – questo pensiero fondamentale appartiene a Marx unicamente ed esclusivamente.1
Lo dissi già molte volte, ma è appunto necessario premetterlo ora al Manifesto stesso.
Londra, 28 giugno 1883.
F. ENGELS.
III.
Dacchè fu scritto quanto sopra, una nuova edizione si rese necessaria del Manifesto e avvennero cose che giova rammentare.
1 “A questo concetto (così io scrissi nella prefazione alla traduzione inglese), che secondo me è destinato a produrre nella scienza storica un progresso eguale a quello che ha prodotto la teoria di Darwin nelle scienze naturali, tanto io quanto Marx ci eravamo avvicinati già varî anni prima del 1845. Il mio libro sulla Situazione delle classi lavoratrici in Inghilterra lo dimostra abbastanza. Ma quando io nel 1845 incontrai Marx a Bruxelles, egli lo aveva già elaborato, tanto che me lo espresse su per giù così chiaramente come io lo esposi qui sopra.”
Nell’82 apparve in Ginevra una seconda traduzione russa, fatta da Vera Zassulitch, la cui prefazione fu stesa da Marx e da me. Non avendo sottomano il manoscritto, devo ritradurre dal russo, dal che il lavoro non guadagna. Quella prefazione diceva:
“La prima edizione russa del Manifesto, tradotto da Bakunin, uscì poco dopo il 1860 dalla tipografia del Kolokol (La Campana). Allora per l’occidente essa non poteva avere maggiore importanza che di curiosità letteraria. Ora non più. Quanto fosse angusta, al primo apparire del Manifesto (gennaio 1848), la cerchia del movimento proletario, lo dice l’ultimo capitolo: Atteggiamento dei comunisti di fronte ai varî partiti di opposizione. La Russia e gli Stati Uniti non vi sono tampoco menzionati. Era il tempo in cui la Russia costituiva l’ultima gran riserva della reazione in Europa e in cui l’emigrazione agli Stati Uniti assorbiva le forze esuberanti del proletariato europeo. Entrambi quei paesi fornivano l’Europa di materie prime e le servivano al tempo stesso di mercato pei suoi prodotti industriali. Così, in una o nell’altra guisa, facevano da contrafforte all’ordine sociale europeo.
“Come tutto ciò s’è mutato! Giust’appunto l’emigrazione europea rese possibile il colossale sviluppo dell’agricoltura americana, che colla concorrenza scrolla le basi della grande come della piccola proprietà terriera in Europa. Essa diede inoltre la possibilità agli Stati Uniti di intraprendere lo sfruttamento delle sue ricche risorse industriali, con tale
energia e in così vasta misura, che in breve porrà fine al monopolio industriale dell’occidente europeo. Entrambe queste circostanze reagiscono poi rivoluzionariamente anche sull’America. La piccola e media proprietà fondiaria dei possidenti-coltivatori, fondamento di tutto l’ordinamento politico americano, cede sempre più alla concorrenza delle fattorie gigantesche, mentre nelle provincie industriali si forma anche là per la prima volta un numeroso proletariato accanto a una favolosa concentrazione dei capitali.
“Passiamo alla Russia. Al tempo della rivoluzione del 48-49, non solo i monarchi, ma gli stessi borghesi europei vedevano nell’intervento russo la sola salvezza contro il proletariato che cominciava ad accorgersi delle proprie forze. Essi proclamavano lo czar capo della reazione europea. Oggi questi si chiude nella sua Gatchina, prigioniero di guerra della rivoluzione, e la Russia si è spinta ben avanti nel movimento rivoluzionario di Europa.
“Il còmpito del Manifesto comunista fu la proclamazione dell’inevitabile e imminente crollo ,della odierna proprietà borghese. Ma in Russia, accanto all’ordinamento capitalistico che febbrilmente si svolge e alla proprietà borghese della terra che si va formando, noi troviamo oltre la metà del suolo tuttora in proprietà comune dei contadini.
“Si pone il problema: la comunità rurale russa, questa forma già in gran parte dissolta della originaria proprietà comune, potrà essa fare immediato passaggio a una forma comunistica più alta di proprietà della terra, o dovrà essa
prima attraversare lo stesso processo di dissoluzione che ci presenta la evoluzione storica dell’occidente?
“Ecco la sola risposta oggi possibile: – Se la rivoluzione russa darà il segnale a una rivoluzione dei lavoratori in occidente, per modo che entrambe si completino assieme, in questo caso la odierna proprietà comune russa potrà servire di punto di partenza a una evoluzione comunistica.
“Londra, 21 gennaio 1882.”
Nella stessa epoca comparve in Ginevra una nuova versione polacca: Manifest kommunistyczny.
Di poi ne comparve un’altra danese nella “Biblioteca socialista, Kjöbenhavn 1885”. Sgraziatamente è incompleta; varî punti essenziali che, pare, allegarono i denti al traduttore, furono omessi, e qua e là si nota una superficialità tanto più spiacevole inquantochè si vede dal lavoro stesso che, con un po’ più di cura, il traduttore avrebbe potuto fare assai meglio.
Nell’86 apparve una nuova traduzione francese nel
Socialiste dì Parigi, che è finora la migliore.
Sulle sue traccie se ne pubblicò nello stesso anno una spagnuola, dapprima nel Socialista di Madrid, poi in opuscolo: Manifesto del Partito comunista por Carlos Marx y F. Engels; Madrid, administracion de El Socialista, Hernan Cortés, 8.
Noto, come curiosità, che nell’87 fu offerto ad un editore di Costantinopoli il manoscritto di una versione
armena; ma il buon uomo non aveva il coraggio di stampare checchessia ove figurasse il nome di Marx e consigliò il traduttore a figurare egli come autore; questi ricusò.
Dopo varie ristampe fatte in Inghilterra delle varie e tutte più o mena inesatte traduzioni americane, comparve alfine una traduzione autentica nel 1888, ad opera del mio amico Samuel Moore, e che fu riveduta anche da me prima della stampa. Essa ha per titolo: Manifesto of the Communist Party, by Carl Marx and Frederick Engels. Authorized English Translation edited and annotated by Frederick Engels, 1888. London. William Reeves, 185, Fleet st. E. C. Io trasferii nella presente varie annotazioni di quella edizione.
Il Manifesto ebbe una propria vita e una propria storia. Salutato con entusiasmo, al suo primo apparire, dall’avanguardia, allora poco numerosa, del socialismo scientifico (come lo provano le traduzioni citate nella prima prefazione), venne poi ben tosto spinto nel retroscena dalla reazione iniziatasi colla sconfitta degli operai parigini nel giugno 48, e infine scomunicato “in nome della legge” colla condanna dei comunisti di Colonia nel novembre 1852. Coi ritirarsi nell’ombra di quel movimento operaio che datò dalla rivoluzione di febbraio, anche il Manifesto ne seguì le sorti.
Quando la classe lavoratrice europea ripigliò forza per un nuovo assalto alle classi dominanti, sorse l’Associazione internazionale dei lavoratori. Essa aveva per iscopo di fondere in un solo gran corpo d’esercito
tutte le sparse forze lavoratrici d’Europa e d’America. Non poteva dunque scostarsi dai principî del Manifesto. Il suo programma non doveva chiudere la porta nè alle Trades-Unions inglesi, nè ai proudhoniani francesi, belgi, italiani e spagnuoli, nè ai lassalliani tedeschi.2 Questo programma, che fa da premessa agli statuti dell’Internazionale, fu disegnato da Marx con maestria che gli fu riconosciuta persino da Bakunin e dagli anarchici. Per la finale vittoria dei principî affermati nel Manifesto, Marx confidava unicamente in quello sviluppo intellettuale delle classi lavoratrici, che doveva scaturire necessariamente dall’azione combinata e dalla discussione. Gli eventi e le vicende della guerra contro il capitale, le sconfitte anche più dei successi, non potevano che dimostrare ai combattenti l’insufficienza delle abituali panacee, e aprir loro la veduta delle vere condizioni della emancipazione operaia. E Marx aveva ragione. La classe lavoratrice del 1874, quando si sciolse l’Internazionale, era tutt’altra da quella dei 1864, quando la si era fondata. Il proudhonismo nei paesi latini, il lassallianismo in Germania erano in agonia, e le stesse Trades-Unions, altre volte così arci-conservatrici, si avvicinavano a grado a grado a quel momento in cui,
2 Lassalle, personalmente, si riconobbe sempre, di fronte a noi, come
“scolaro” di Marx, e come tale va da sè che accettava i principî del Manifesto. Altro è il caso di quei suoi seguaci che non seppero oltrepassare la sua richiesta delle associazioni di produzione accreditate dallo Stato e divisero tutta la classe lavoratrice in lavoratori che chiedono l’aiuto dello Stato e lavoratori che intendono aiutarsi da sè (più efficacemente nel testo: Staatshülfler und Selbsthülfler).
nel 1887, il presidente d’un loro Congresso, a Swansea, potè dire in loro nome: “Il socialismo continentale ha cessato d’essere per noi uno spauracchio.” Questo socialismo continentale già nell’87 era su per giù una cosa sola colla teoria affermata nel Manifesto. E così la storia del Manifesto rispecchia fino a un certo segno la storia del moderno movimento proletario dal 1848. Attualmente esso è per fermo il prodotto più diffuso e più internazionale di tutta quanta la letteratura socialista, il programma comune di molti milioni di lavoratori di ogni paese, dalla Siberia alla California.
Pure, quando comparve, non lo potemmo intitolare Manifesto socialista. Con questo aggettivo nel 1847 si qualificavano due specie di individui. Da un lato i seguaci de’ varî sistemi utopistici, specialmente in Inghilterra gli owenisti e in Francia i fourieristi, gli uni e gli altri già ridotti a semplice sêtte, agonizzanti a poco a poco. D’altro canto i molteplici dulcamara sociali, che colle loro varie panacee e con ogni sorta di rattoppi volevano guarire le miserie sociali, senza fare alcun male al capitale e al profitto. In ambo i casi, gente che stava al di fuori del movimento operaio e che cercava sostegno fra le classi “colte”.
Al contrario quella parte di lavoratori che, esperta dell’insufficienza di semplici rivoluzioni politiche, chiedeva una trasformazione radicale della società, quella si chiamava allora comunista. Era un comunismo appena sbozzato ed istintivo, talora un po’ greggio, ma forte abbastanza da aver prodotto due sistemi di
comunismo utopistico, in Francia il comunismo dell’Icaria di Cabet, in Germania quello di Weitling. Nel 1847 “socialismo” significava un movimento borghese,
“comunismo” un movimento operaio. Il socialismo, almeno sul continente, era una dottrina da salotti, il comunismo era giusto il contrario. E poichè noi fin d’allora eravamo ben decisi nell’idea che
“l’emancipazione dei lavoratori deve essere l’opera della classe lavoratrice”, è chiaro che non potevamo rimanere in dubbio un istante sulla scelta fra i due nomi. Nè mai di poi ci passò per il capo di mutarla.
“Proletarî di tutti i paesi, unitevi!” Solo poche voci risposero, quando noi lanciammo pel mondo questo grido, sono ormai 42 anni, alla vigilia della prima delle rivoluzioni parigine, in cui il proletariato insorgesse in nome di rivendicazioni sue proprie. Ma nel 28 settembre 1864 i proletarî della più parte delle nazioni occidentali d’Europa si unirono nell’Associazione internazionale di gloriosa memoria. L’Internazionale non visse che nove anni; ma che il vincolo eterno stretto da essa fra i lavoratori d’ogni paese duri ancora, e sia più forte che mai, nessuna miglior prova che la giornata d’oggi. Perocchè oggi, mentre io scrivo queste righe, il proletariato europeo ed americano passa in rassegna le sue forze di battaglia per la prima volta mobilizzate; mobilizzate come un solo esercito, sotto un solo stendardo, per un solo scopo immediato: quella giornata normale di otto ore, da ottenersi per legge, che già proclamarono il Congresso dell’Internazionale a
Ginevra nel 66 e il Congresso operaio di Parigi nell’89. E lo spettacolo di questa giornata persuaderà ai capitalisti e ai proprietari del suolo, in ogni paese, che i proletarî di tutti i paesi sono uniti di fatto.
Fosse soltanto ancora Marx accanto a me, a veder questo coi proprî occhi!
Londra, 1.° maggio 1890.
F. ENGELS.
MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA
C’è uno spettro in Europa – lo spettro del Comunismo. Ed ecco tutte le potenze di questa vecchia Europa, il papa e lo czar, Metternich e Guizot, i radicali francesi e i poliziotti tedeschi, uniti per dargli con furor sacro la caccia.
I partiti di opposizione non son forse tacciati di Comunismo dagli uomini al potere? E gli stessi partiti di opposizione non ripetono il giuoco degli avversarî respingendo da sè i più avanzati col rovente rimprovero di Comunismo?
Da questo fatto si possono concludere due cose:
Il Comunismo è riconosciuto una forza dalle potenze europee;
È tempo finalmente che i comunisti espongano chiaramente a tutti i loro modi di vedere, i loro scopi, le loro tendenze; e alla burletta dello spettro rispondano col manifesto del partito.
A tale intento i comunisti delle varie nazioni, adunati a Londra, compilarono il seguente manifesto, che verrà pubblicato in lingua inglese, francese, tedesca, italiana, olandese e danese.
I.
Borghesi e proletarî.
La storia della società sinora esistita3 è la storia di una lotta di classi.
Liberi e schiavi, patrizî e plebei, baroni e servi, capi di maestranze e garzoni, in una parola oppressori ed oppressi, furono sempre in contrasto, e continuarono, in modo nascosto o palese, una lotta che finì sempre colla trasformazione rivoluzionaria di tutta la società o colla comune rovina delle classi lottanti.
Nelle prime epoche storiche troviamo quasi da per tutto una completa divisione organica della società in caste, una multiforme gradazione di condizioni sociali. Nell’antica Roma abbiamo i patrizî, i cavalieri, i plebei, gli schiavi; nel medio evo, i signori, i vassalli, le maestranze, i garzoni, i servi, e in ciascuna di queste classi si notano speciali gradi.
La moderna società borghese, nata sulle rovine della feudale, non tolse gli attriti di classe; creò soltanto
3 O, a dir meglio, la storia scritta. Nel 1847 la preistoria sociale, precedente a tutte le storie scritte, era come sconosciuta. Dopo che Haxthausen ebbe scoperta la proprietà comune del suolo in Russia, Maurer dimostrò esser essa la base sociale da cui mossero storicamente tutte le stirpi tedesche, e a poco a poco si trovò che il Comune agricolo col possesso del suolo in comune era la forma primitiva della società dall’India fino all’Irlanda. Coronò queste indagini la grande scoperta di Morgan della vera natura della gens e della posizione di questa nella stirpe, scoperta che mise a nudo la organizzazione intima di codesta primitiva società comunista. Collo sciogliersi di queste comunità primitive ha principio la divisione della società in classi distinte, che diventano poi antagonistiche.
nuove classi, nuove condizioni di oppressione e nuove forme di lotta in luogo delle antiche.
L’epoca nostra, l’epoca della borghesia, si distingue tuttavia per una semplificazione nella lotta di classe. Tutta la società si scinde sempre meglio in due vasti campi nemici, in due classi che si fanno fronte: la Borghesia e il Proletariato.
Dai servi del medio evo uscirono gli abitatori dei primi borghi, e da questi borghigiani ebbero sviluppo i primi elementi della borghesia.
La scoperta dell’America e la circumnavigazione dell’Africa offrirono nuovo campo all’adolescente borghesia. Il mercato delle Indie orientali e della China, la colonizzazione dell’America, i traffici colle colonie, l’aumento dei mezzi di scambio e sopratutto delle merci, diedero un impulso sin allora sconosciuto ai commerci, alla navigazione, all’industria, e in tal modo rapidamente svilupparonsi gli elementi rivoluzionarî nella cadente società feudale.
Il modo di produzione dell’industria feudale o corporativa non bastò più ai crescenti bisogni dei mercati nuovi. Gli succedette la manifattura. Un medio ceto industriale rovesciò le maestranze; la divisione del lavoro per corporazioni scomparve davanti alla divisione del lavoro nelle singole officine.
Ma i mercati ingrandivano sempre e i bisogni crescevano. Anche la manifattura non bastò più.
Intanto il vapore e le macchine misero la rivoluzione nella produzione industriale.
Alla manifattura succedette la grande industria moderna; al medio ceto industriale succedettero i borghesi milionari, capitani degli eserciti industriali.
La grande industria aperse il mercato mondiale, già preparato dalla scoperta d’America. Il mercato mondiale ha dato al commercio, alla navigazione e alla viabilità continentale un immenso sviluppo, il quale a sua volta ha reagito sull’espandersi dell’industria; la borghesia, sviluppandosi proporzionalmente colle industrie, coi commerci, colla navigazione e colle ferrovie, crebbe, aumentò i suoi capitali e lasciò nel retroscena le classi sopravvissute al medio evo.
Così dunque la stessa borghesia moderna è il prodotto di un lungo e continuo sviluppo, di una serie di sconvolgimenti nei modi di produzione e di scambio.
Ognuno di questi stadî della borghesia si accompagnò ad un progresso politico. Casta oppressa sotto il dominio dei baroni, associazione armata ed autonoma nei Comuni4, qui repubblica civica indipendente, là terzo stato tributario della monarchia; poi, al tempo della manifattura, antagonista della nobiltà nelle monarchie dinastiche o assolute, sempre fondamento cardinale delle vaste monarchie, la borghesia, collo stabilirsi della grande industria e del mercato mondiale, si conquista finalmente l’esclusivo dominio politico nei moderni Stati rappresentativi. Il potere dello Stato oggi
4 Così in Italia e in Francia gli abitanti delle città chiamavano l’aggregato cittadino dopo avere strappate o comperate le prime franchigie amministrative dai signori feudali.
è un comitato che amministra gli affari sociali del ceto borghese.
La borghesia ebbe nella storia un ufficio sommamente rivoluzionario.
Dov’è giunta al potere, ha distrutto i rapporti feudali, patriarcali e idillici. Ha stracciato senza pietà i variopinti lacci feudali che stringevano l’uomo ai suoi naturali superiori, e non ha lasciato fra uomo e uomo altro legame che il nudo interesse e l’arido “pagamento a pronti”. Ha affogato i santi fremiti dell’esaltazione religiosa, il cavalleresco entusiasmo, le malinconie dei cittadini all’antica, nell’acqua gelida del calcolo egoistico. Ha valutato quanto si paga la dignità personale e, in luogo delle innumerevoli franchigie conquistate e patentate, ne proclamò una sola: la libertà di commercio senza scrupoli. In una parola, invece dello sfruttamento velato da illusioni religiose e politiche, lo sfruttamento palese, senza pudore e senza viscere.
La borghesia ha tolto l’aureola alle azioni finora credute onorevoli e considerate con pio terrore. Ha trasformato il medico, il legale, il prete, il poeta, lo scienziato, in lavoratori salariati.
La borghesia ha strappato il velo di tenero sentimentalismo che avvolgeva i rapporti di famiglia, e li ha ridotti a un semplice rapporto di quattrini.
La borghesia ci ha rivelato che la brutale manifestazione di forza, per cui i reazionarî ammirano il medio evo, aveva il suo naturale complemento nella più sconcia poltroneria. Essa fu la prima a mostrare di che
sia capace l’attività umana. Essa ha compiuto ben altre meraviglie che non le piramidi d’Egitto, gli acquedotti romani e le cattedrali gotiche; ha fatto ben altre spedizioni che gli esodi di popoli e le crociate.
La borghesia non può esistere senza una perpetua rivoluzione negli strumenti di produzione: e perciò anche nei rapporti di produzione, e nei rapporti sociali tutt’insieme. Condizione di esistenza delle classi industriali che la precedettero era invece l’immutabile mantenimento dei vecchi metodi di produzione. L’epoca borghese si distingue da tutte le precedenti pel continuo sconvolgersi della produzione, per l’incessante scuotersi di ogni condizione sociale, per l’incertezza e il movimento perpetuo. Le dure e rugginose relazioni, cui andavano unite maniere di vedere e di pensare rese venerabili dall’età, vengono sciolte, e le nuove invecchiano prima ancora di ossificarsi. Il gerarchico e lo stabilito se ne vanno, il sacro è sconsacrato, e gli uomini sono finalmente costretti a guardare, spoglie d’ogni velo, le loro condizioni di esistenza e i loro rapporti reciproci.
Il bisogno di sfoghi sempre maggiori ai suoi prodotti spinge la borghesia su tutto il globo terrestre. Dappertutto essa deve ficcarsi, iniziare e stabilire relazioni.
Sfruttando il mercato mondiale essa rese cosmopolita la produzione e il consumo d’ogni paese. A dispetto dei reazionarî, tolse all’industria il carattere nazionale. Le antiche industrie nazionali furono e vengono
continuamente annichilite. Sono schiacciate da nuove industrie la cui introduzione è questione di vita per le nazioni civili, industrie che lavorano non più la materia prima paesana, ma quella delle più lontane regioni, e i cui manufatti non si consumano soltanto nel sito, ma in tutte le parti del mondo. Invece dei vecchi bisogni, soddisfatti dalla produzione locale, se ne manifestano altri che richiedono, per esser soddisfatti, i prodotti dei paesi e dei climi più lontani. All’antico isolamento locale, per cui ogni nazione bastava a sè stessa, succede il traffico universale e la dipendenza delle nazioni una dall’altra. E come la produzione materiale, così si modifica la spirituale. Ciò che produce il pensiero delle singole nazioni diventa patrimonio comune. L’unilateralità e l’esclusivismo nazionale si rendono sempre meno possibili, e dalle molte letterature nazionali e locali esce una letteratura mondiale.
La borghesia col rapido miglioramento di tutti gli strumenti di produzione, colle comunicazioni infinitamente agevolate, attrae nella civiltà anche le nazioni più barbare. I prezzi tenui delle sue merci sono l’artiglieria di grosso calibro che abbatte ogni muraglia della China, che costringe a capitolare l’orgoglioso odio dei barbari per lo straniero. Essa fa legge a tutte le nazioni di adottare i metodi borghesi della produzione per evitare la catastrofe; le forza ad accettare la cosidetta civiltà, cioè a rendersi borghesi. In una parola essa si crea un mondo a propria imagine.
La borghesia ha soggettato la campagna alla città. Ha
creato città enormi, aumentandone immensamente gli abitanti in confronto di quelli delle campagne; così una parte considerevole della popolazione è strappata all’ignoranza della vita rustica. Nello stesso modo che ha sottomesso i campi alla città, ha reso dipendenti dai civili i paesi barbari e semibarbari, i contadini dai cittadini, l’Oriente dall’Occidente.
La borghesia sopprime sempre più i piccoli mezzi di produzione, la proprietà e la popolazione frazionata. Agglomerò la popolazione, e accentrò in poche mani i mezzi di produzione. Conseguenza necessaria fu l’accentramento politico. Provincie indipendenti o unite appena con debole legame, aventi interessi, leggi, governi e dogane diverse, furono strette in unica nazione con governo unico, unica legge, unico interesse nazionale di classe, unico confine doganale.
Nel suo quasi secolare dominio di classe la borghesia ha creato forze di produzione più gigantesche e imponenti che non abbian fatto tutte insieme le passate generazioni. Sottomissione delle forze naturali, invenzioni meccaniche, applicazione della chimica all’industria e all’agricoltura, navigazione a vapore, ferrovie, telegrafi elettrici, dissodamenti di intere parti del mondo, fiumi resi navigabili, intere popolazioni sorte per incanto dal suolo, ecco ciò che essa ha fatto. Quale dei secoli trascorsi presentì che tante forze di produzione stessero sopite in grembo al lavoro sociale?
Noi vedemmo dunque come i mezzi di produzione e di traffico, sui cui fondamenti si eresse la borghesia, si
generarono in seno alla società feudale. A un certo grado del loro sviluppo non corrisposero più i metodi di produzione e di commercio della società feudale, l’organizzazione feudale dell’agricoltura e della manifattura; in una parola i rapporti feudali della proprietà furono disadatti alle forze produttive già sviluppate, impacciarono la produzione anzichè agevolarla, divennero altrettanti ostacoli. Dovevano essere abbattuti e lo furono.
Sorse invece di questi la libera concorrenza con adatte costituzioni sociali e politiche, col dominio economico e politico della classe borghese.
Oggi accadono fatti analoghi sotto i nostri occhi. Si sta a disagio nei rapporti borghesi di produzione, di traffico, di proprietà, e la società moderna, che ha fatto nascere per incanto mezzi di produzione e di scambio così potenti, somiglia al mago che ha evocato le potenze sotterranee e non può più dominarle.
Da qualche diecina d’anni5 la storia dell’industria e del commercio è la storia delle moderne forze produttive che si ribellano contro gli attuali rapporti di produzione e di proprietà, condizioni della vita e del dominio borghese. Basti accennare alle crisi commerciali che nei loro ritorni periodici sempre più minacciosi mettono in forse l’esistenza della società borghese. Nelle crisi commerciali viene distrutta regolarmente non solo gran parte dei prodotti, ma anche
5 Ricordiamo che il Manifesto fu pubblicato la prima volta in principio del 1848.
delle forze produttive che erano state create.
In queste crisi scoppia un’epidemia sociale che sarebbe apparsa un controsenso in altre epoche – l’epidemia della sovrapproduzione. La società si trova improvvisamente ricacciata in uno stato di momentanea barbarie; una carestia, una guerra generale di sterminio sembrano averle tolti i mezzi di esistenza; l’ industria, il commercio sembrano annientati, e perchè? Perchè essa possiede troppa civiltà, troppi mezzi di esistenza, troppa industria, troppo commercio. Le forze produttive di cui essa dispone non valgono più a conservare i rapporti della proprietà borghese; al contrario sono divenute troppo violenti per questi rapporti, che le inceppano, e quando rompono le catene scompigliano tutta la società borghese e minacciano di morte la sua proprietà. Troppo angusti sono ormai i rapporti della borghesia per contenere la ricchezza creata da essi.
Come la borghesia supera le crisi? Un po’ distruggendo forzatamente molte energie produttive, un po’ conquistando nuovi mercati e sfruttando più radicalmente gli antichi. Che ne segue? Che essa prepara crisi più violente e generali, diminuendo i mezzi di rimediarvi.
Le armi con cui la borghesia abbattè il feudalismo ora son volte appunto contro di essa.
Ma la borghesia non soltanto fabbricò le armi che la uccidono; ha creato anche gli uomini che le porteranno – i moderni operai, i proletarî.
Nella stessa proporzione in cui si sviluppa la
borghesia, cioè il capitale, si sviluppa anche il proletariato, l’attuale classe operaia, che vive finchè trova lavoro e trova lavoro finchè questo conserva la facoltà di aumentare il capitale. Gli operai, costretti a vendersi al minuto, non sono che una merce come un’altra, e perciò esposti a tutte le vicissitudini della concorrenza, a tutte le oscillazioni del mercato.
Il lavoro dei proletarî, coll’estendersi del macchinismo e della divisione del lavoro, ha perduto ogni carattere di indipendenza e quindi ogni attrattiva per l’operaio, il quale diventa un accessorio della macchina, dal quale non si esige che un’attitudine estremamente semplice, monotona e facilissima ad acquistare. Il costo di un operaio si limita perciò ai mezzi di sussistenza necessarî a mantenerlo in vita e a perpetuarne la razza. Il prezzo di ogni merce, e quindi anche il prezzo del lavoro, è uguale al suo costo di produzione. Così più il lavoro si fa ripugnante, più ribassano le mercedi. Più ancora: quanto più si sviluppano il macchinismo e la divisione del lavoro, cresce anche in proporzione la somma del lavoro, o coll’aumento degli orarî, o del lavoro richiesto in una data misura di tempo, o della celerità delle macchine, ecc.
L’industria moderna trasformò la botteguccia patriarcale del vecchio padrone nell’opificio del capitalista industriale. Le masse degli operai, addensate nelle fabbriche, sono organizzate militarmente. Come gregarî dell’industria essi sono irreggimentati sotto la
sorveglianza di tutta una gerarchia di sottufficiali e ufficiali. Non soltanto sono servi della classe e dello Stato borghese, ma soggetti ogni giorno e ogni ora alla macchina, al soprastante, e specialmente al privato borghese industriale; dispotismo tanto più meschino, odioso ed amaro, quanto più apertamente il guadagno ne è proclamato l’unico obiettivo.
Quanto meno il lavoro esige abilità e forza, o in altre parole quanto più l’industria moderna si sviluppa, tanto più il lavoro degli uomini è respinto e sostituito da quello delle donne. Le differenze di sesso e d’età perdono, per la classe lavoratrice, ogni significato sociale. Non vi sono più che degli strumenti di lavoro il cui costo varia col sesso e coll’età.
E non appena l’operaio ha finito di subire lo sfruttamento del fabbricante e ne ha intascato il salario, ecco piombargli addosso il resto della borghesia, il padrone di casa, il bottegaio, il pignoratario, ecc.
Quel che fu finora il medio ceto, piccoli industriali, mercanti, piccoli proprietari, artigiani, agricoltori, tutti costoro cadono nel proletariato, o perchè il loro esiguo capitale non basta all’esercizio della grande industria e la concorrenza dei maggiori capitalisti li schiaccia, o perchè le loro attitudini tecniche hanno perduto valore coi nuovi metodi di produzione. Così il proletariato si recluta in tutte le classi sociali.
Il proletariato traversa diversi gradi di sviluppo. La sua lotta contro la borghesia comincia dal suo nascere.
Prima lottano i singoli operai ad uno ad uno, poi gli
operai di una fabbrica, indi quelli di una data arte in un dato luogo contro il singolo borghese che li sfrutta direttamente. Essi non attaccano soltanto il sistema borghese di produzione, ma gli stessi strumenti di lavoro; essi distruggono le merci estere che fanno concorrenza ai loro prodotti, spezzano le macchine, incendiano le fabbriche, e tentano ristabilire la condizione degli artieri del medio evo, ornai tramontata per sempre.
In tale stadio gli operai formano una massa dispersa per tutto il paese e disgregata dalla concorrenza. I loro aggruppamenti in grandi masse non sono la conseguenza di una coesione loro propria, ma dell’unione della borghesia che, pei suoi scopi politici, deve mettere in moto il proletariato e lo può ancora. In tale stadio i proletarî combattono non già i loro nemici, ma i nemici dei loro nemici, gli avanzi della monarchia assoluta, i proprietari fondiarî, i borghesi non industriali, la piccola borghesia.
Tutto il movimento storico è così concentrato in mano alla borghesia; ogni vittoria così ottenuta è una vittoria della borghesia.
Ma collo sviluppo industriale il proletariato non cresce soltanto di numero; addensato in grandi masse, esso si rinforza e acquista coscienza delle sue forze crescenti. Gli interessi e le condizioni di esistenza del proletariato si allivellano sempre più, mentre il macchinismo annienta le differenze del lavoro e riduce quasi da per tutto le mercedi a un livello ugualmente
infimo. La crescente concorrenza dei borghesi fra loro e le crisi che ne derivano rendono sempre più oscillanti le mercedi degli operai; il sempre più rapido sviluppo e l’incessante perfezionarsi del macchinismo rende sempre più incerte le loro condizioni di esistenza; e le collisioni fra singoli operai e singoli borghesi vanno sempre più assumendo carattere di una collisione di due classi. Gli operai cominciano a coalizzarsi contro i borghesi; si uniscono per tutelare le loro mercedi; fondano associazioni stabili per assicurarsi da vivere durante gli eventuali conflitti. Qua e là la lotta diventa insurrezione.
Gli operai vincono di quando in quando, ma sono vittorie effimere. Il vero risultato della loro lotta non è l’immediato successo, bensì l’organizzazione più estesa dei lavoratori. Essa è agevolata dai crescenti mezzi di comunicazione creati dalla grande industria; operai delle diverse località si alleano, e basta la sola loro unione, perchè le molte lotte locali, avendo quasi da per tutto lo stesso carattere, si accentrino in una lotta nazionale, in una lotta di classe. Ma ogni lotta di classe è lotta politica. E l’organizzazione, per raggiungere la quale ai borghigiani del medio evo, colle loro strade vicinali, abbisognarono secoli, oggi, colle ferrovie, i proletarî la effettuano in pochi anni.
Questa organizzazione dei proletarî in classe, e quindi in partito politico, viene ad ogni istante incagliata dalla concorrenza che si fanno i lavoratori stessi; ma rinasce sempre più forte, più salda e potente, e profittando delle
scissioni della borghesia costringe la legge a riconoscere gli speciali interessi degli operai. Il bill delle dieci ore, in Inghilterra, non ebbe altra origine.
Le collisioni della vecchia società favoriscono in più modi lo svilupparsi del proletariato. La borghesia lotta senza posa: dapprima contro l’aristocrazia, poi contro quelle parti di se stessa i cui interessi contrastano ai progressi dell’industria; sempre poi colle borghesie straniere. In tutte queste lotte è costretta a far appello al proletariato, a chiederne l’aiuto, a trascinarlo nel moto politico, dandogli così quei mezzi di educazione che si convertono in armi contro di essa.
Vedemmo inoltre come, per il progresso delle industrie, intere parti costitutive della classe dominante sono respinte nel proletariato, o per lo meno minacciate nelle loro condizioni di esistenza.
Anche queste forniscono molti elementi di educazione al proletariato.
Finalmente, in tempi in cui la lotta di classe si avvicina a soluzione, il disgregamento prende, nella classe dominante, nella vecchia società, carattere così crudo e violento, che una piccola parte dei dominatori diserta e si unisce ai rivoluzionarî di quella classe che ha con sè l’avvenire. Come un tempo una parte della nobiltà passò alla borghesia, così ora una parte della borghesia passa al proletariato; e sono quei borghesi ideologi che giunsero alla comprensione teorica del movimento della storia.
Di tutte le classi che oggi stanno contro la borghesia,
il solo proletariato è classe veramente rivoluzionaria; le altre classi, colla grande industria, decadono e soccombono; il proletariato invece ha vita da essa.
I ceti medii, piccoli industriali, piccoli mercanti, artigiani, agricoltori, combattono tutti la borghesia per conservare la loro esistenza di medio ceto. Non sono dunque rivoluzionarî, ma conservatori; più ancora sono reazionarî; essi tentano girare all’indietro la ruota della storia. Se mai sono rivoluzionarî, non lo sono che in quanto si sentono minacciati di cadere nel proletariato, ed allora non difendono già i loro interessi del momento, ma quelli dell’avvenire, e abbandonano il loro proprio punto di veduta per collocarsi a quello del proletariato.
La parte più misera del proletariato, codesta decomposizione affatto passiva degli infimi strati della vecchia società, può essere attratta qua e là nel moto della rivoluzione proletaria, ma tutte le sue condizioni di vita la dispongono piuttosto a lasciarsi comprare dalla reazione.
Le condizioni di vita della vecchia società, non esistono più nel proletariato. Il proletario non ha proprietà; le sue relazioni colla donna e coi figli nulla hanno di comune colla famiglia borghese; il lavoro industriale moderno, il moderno giogo del capitale, ch’è lo stesso in Inghilterra ed in Francia, in America ed in Germania, ha cancellato da lui ogni carattere nazionale. Leggi, morale e religione non sono più per lui che tanti pregiudizi borghesi, dietro i quali si nascondono altrettanti interessi borghesi.
Tutte le classi, che finora hanno conquistato il dominio, cercarono di guarentirsi la raggiunta posizione sociale, sottomettendo l’intera società alle condizioni più vantaggiose pel loro sistema di sfruttamento. I proletarî non possono conquistare le forze produttive della società che abolendone il modo di appropriazione, e con esso tutti i modi di appropriazione usati sinora. I proletarî non hanno niente di proprio da assicurare, devono anzi distruggere la sicurezza e la garanzia privata finora esistite.
Tutti i moti furono sinora di minoranze o nel vantaggio delle minoranze. Il moto proletario è il moto indipendente dell’immensa maggioranza pel vantaggio dell’immensa maggioranza. Il proletariato, ultimo strato dell’attuale società, non può elevarsi nè rizzarsi senza spezzare tutta la massa degli strati superiori che costituiscono la società ufficiale.
La sua lotta contro la borghesia è anzitutto nazionale, ma piuttosto nella forma che nella sostanza. Il proletariato di un dato paese deve naturalmente prima sbarazzarsi della propria borghesia.
Accennando sommariamente le fasi di sviluppo del proletariato, abbiamo seguito le guerre intestine più o meno latenti che avvengono nella società sino al punto in cui scoppiano in aperta rivoluzione, e col violento tracollo della borghesia il proletariato stabilisce il suo dominio.
Tutta la società visse sinora, come vedemmo, sul contrasto fra oppressori e oppressi. Però, a mantenere
oppressa una classe, bisogna che siano assicurate le condizioni in seno alle quali la sua esistenza schiava possa almeno prolungarsi. Il servo medioevale si è preparato ad essere membro del Comune durante la servitù come il borghigiano s’è fatto borghese sotto il giogo dell’assolutismo feudale. Ma il moderno operaio, invece di elevarsi col progresso dell’industria, cade sempre più basso, al disotto delle condizioni della propria classe. L’operaio si trasforma nel povero, e il pauperismo aumenta assai più rapidamente della popolazione e della ricchezza. Risulta quindi evidente che la borghesia non può rimanere a lungo classe dominatrice della società, nè imporle come legge regolatrice le condizioni della propria esistenza. È inetta a dominare, perchè non può assicurare al suo schiavo la vita insieme colla schiavitù ed è costretta a lasciarlo cadere in condizioni da doverlo nutrire anzichè esser nutrita da lui. La società non può più sottostarle, perchè l’esistenza della borghesia non è più compatibile colla società.
Condizione essenziale dell’esistenza e del dominio della classe borghese è l’accumularsi delle ricchezze in mano ai privati, la formazione e l’accrescimento del capitale; e condizione del capitale è il lavoro salariato che importa come ultimo effetto la concorrenza degli operai fra di loro. Il progresso dell’industria, del quale la borghesia è la involontaria e fatale apportatrice, invece di isolare i lavoratori colla concorrenza, dà loro una coesione rivoluzionaria mediante l’associazione.
Collo sviluppo della grande industria sfugge così sotto i piedi stessi della borghesia il terreno sul quale essa produce e si appropria i prodotti. La borghesia produce sopratutto il proprio becchino. Il suo tramonto e il trionfo del proletariato sono ugualmente inevitabili.
II
Proletarî e comunisti
In che rapporti si trovano i comunisti coi proletarî in generale?
I comunisti, rispetto agli altri partiti operai, non sono un partito speciale.
Non hanno interessi separati da quelli di tutto il proletariato.
Non erigono alcun principio speciale a cui vogliano informare il moto proletario.
I comunisti non si distinguono dagli altri partiti proletarî che su due punti: da un lato, nelle varie lotte nazionali del proletariato pongono in rilievo gli interessi che sono comuni ai proletarî indipendentemente dalla nazionalità: d’altro canto, nei vari stadî attraversati dalla lotta fra proletariato e borghesia, difendono sempre l’interesse del movimento generale.
Così, praticamente, i comunisti sono la schiera più risoluta e progressiva dei partiti operai d’ogni paese; teoricamente conoscono, meglio della restante massa del proletariato, le condizioni, l’andamento e i risultati generali del moto proletario.
Lo scopo immediato dei comunisti è quello stesso degli altri partiti proletarî: organizzazione del proletariato in partito di classe, distruzione del dominio borghese, conquista della forza politica per parte del proletariato.
I postulati teorici dei comunisti non riposano niente affatto sopra idee o principî, inventati o scoperti da qualche riformatore della società.
Essi non sono che le espressioni generali dei rapporti effettivi di una lotta di classe già esistente, di un moto storico spontaneo che si svolge sotto i nostri occhi. L’abolizione dei rapporti di proprietà finora esistiti non è cosa che distingua propriamente il comunismo.
Tutti i rapporti di proprietà subirono un continuo mutamento, una continua trasformazione storica.
La rivoluzione francese, per esempio, abolì la proprietà feudale a favore della borghese.
Ciò che distingue il comunismo non è l’abolizione della proprietà in generale, bensì l’abolizione della proprietà borghese.
Ma la moderna proprietà borghese privata è l’ultima e più completa espressione di quella produzione e di quella appropriazione dei prodotti, che han per base l’antagonismo delle classi e lo sfruttamento dell’uomo.
In questo senso i comunisti possono riassumere la loro teoria in una frase: abolizione della proprietà privata.
Si è rimproverato a noi comunisti di voler abolire la proprietà personalmente acquistata col lavoro; quella proprietà che è fondamento di ogni libertà personale, di ogni attività e di ogni indipendenza.
La proprietà lavorata, guadagnata e meritata! Si allude forse alla proprietà del piccolo borghese e del piccolo agricoltore che precedette la proprietà borghese? Ma cotesta non abbiamo bisogno d’abolirla; lo sviluppo
dell’industria l’ha abolita e l’abolisce quotidianamente.
Ovvero si allude alla moderna proprietà privata borghese? Può il proletario acquistare questa proprietà col salario, col lavoro? No. Il lavoro crea il capitale, crea la proprietà sfruttatrice dei salariati, che non aumenta se non a condizione di creare nuovi salariati per poterli nuovamente sfruttare.
La proprietà, qual è oggi, nasce dall’antagonismo fra capitale e lavoro salariato. Consideriamo questo antagonismo sotto il suo doppio aspetto.
Esser capitalista non vuol dire possedere soltanto una posizione personale; vuol dire tenere una posizione sociale nella produzione. Il capitale è un prodotto comune, risulta solo dall’attività cooperante di molti, e in ultima analisi non può essere impiegato che dall’attività comune di tutti i membri della società.
Il capitale dunque non è una forza personale; è una forza sociale.
Ma se esso diventa proprietà sociale appartenente a tutti, non v’è trasformazione di una proprietà personale in sociale. Cambia solo il carattere sociale della proprietà. Essa perde il carattere di classe.
Passiamo ai salarî.
La media del salario è il minimo salario possibile, ossia la somma dei mezzi di esistenza necessarî a mantenere in vita il lavoratore come tale. Il salariato colla sua attività si appropria il puro necessario per campare la vita e riprodursi. Noi non vogliamo abolire in nessun modo questa appropriazione personale che si
compie del prodotto del proprio lavoro pel mantenimento della vita immediata, appropriazione la quale non lascia rendite che diano modo di dominare sul lavoro altrui. Noi non vogliamo che toglierle quel carattere di miseria per cui l’operaio non vive che per l’incremento del capitale e in quanto lo esige l’interesse della classe dominatrice.
Nella società borghese il lavoro vivente non è che un mezzo per accrescere il lavoro accumulato. Nella società comunista il lavoro accumulato non è invece che un mezzo per rendere più lunga ed agiata la vita del lavoratore.
Così, nella società borghese il passato domina il presente; nella società comunista è invece il presente che domina il passato. Nella società borghese il capitale è indipendente e personale, l’individuo attivo è dipendente ed impersonale.
L’abolizione di questi rapporti è chiamata dalla borghesia abolizione della personalità e della libertà! E non a torto. Si tratta infatti di abolire la personalità, l’indipendenza, la libertà borghese.
Per libertà, negli attuali rapporti borghesi della produzione, s’intende la libertà del commercio, della compera e della vendita.
Tolto il commercio, sparisce la libertà del commercio. L’espressione di libero commercio, come in genere tutte le altre ostentazioni liberalesche della nostra borghesia, ha un senso in paragone al commercio schiavo, ai borghesi asserviti del medio evo, ma non ne ha alcuno
rimpetto all’abolizione comunista del commercio, dei rapporti borghesi di produzione e della borghesia stessa. Voi inorridite all’idea che vogliamo abolire la proprietà privata. Ma nell’attuale società questa proprietà privata è abolita per nove decimi dei suoi membri; anzi essa non esiste che in quanto è tolta a quei nove decimi. Voi ci rimproverate di voler abolire una proprietà che ha per condizione necessaria la
nullatenenza della sterminata maggioranza sociale.
Insomma, ci rimproverate di voler abolire la vostra proprietà. Certo, lo vogliamo.
Dall’istante in cui il lavoro non può più trasformarsi in capitale, in danaro, in rendita fondiaria, insomma in una forza sociale monopolizzabile, dall’istante in cui la proprietà personale non può più trasformarsi in proprietà borghese, voi dichiarate ch’è abolita la persona.
Con ciò confessate che per persona voi non intendete altro che il borghese. Questa persona deve per fermo abolirsi.
Il comunismo non toglie ad alcuno la facoltà di appropriarsi i prodotti sociali; impedisce soltanto di valersene per asservire il lavoro altrui.
Si ribatte che coll’abolizione della proprietà privata cesserebbe ogni attività e regnerebbe una inerzia generale.
Se fosse così, la società borghese sarebbe da tempo andata in rovina, giacchè in essa chi lavora non guadagna e chi guadagna non lavora. Tutta l’obiezione
si riduce a questa tautologia: che non c’è lavoro salariato, se non c’è capitale.
Le obiezioni alla teoria comunista di appropriazione e creazione di prodotti naturali vengono estese all’appropriazione e creazione di prodotti spirituali. Come per il borghese cessa la produzione cessando la proprietà di classe, così il perdersi dell’educazione di classe è per lui lo stesso come il perdersi di ogni coltura. L’educazione di cui egli teme la perdita è, per la gran maggioranza, una educazione di adattamento alla
macchina.
Ma cessate dal polemizzare con noi, finchè non sapete considerare l’abolizione della proprietà borghese che alla stregua dei concetti borghesi di libertà, di educazione, di diritto, ecc. Le vostre idee sono anch’esse un prodotto dei rapporti borghesi di produzione e di proprietà, come il vostro diritto non è che la volontà della vostra classe convertita in legge, volontà che è conseguenza delle vostre condizioni materiali.
Il concetto interessato che vi siete fatto dei vostri rapporti di produzione e di proprietà, che cioè essi non siano già meri rapporti storici e transeunti coll’evoluzione della produzione, ma leggi eterne di natura e di ragione; lo ebbero al pari di voi tutte le classi dominanti che tramontarono. Ciò che riescite a capire per l’antica proprietà, ciò che capite per la proprietà feudale, non volete capirlo più quando si tratta della proprietà borghese.
Abolizione della famiglia! Perfino i radicalissimi si scandalizzano di così oscena intenzione dei comunisti.
Su che si basa la famiglia odierna, la famiglia borghese? Sul capitale, sull’industria privata. Nel suo pieno sviluppo la famiglia esiste soltanto per la borghesia; ma il suo complemento necessario è la mancanza di famiglia pei proletarî e la pubblica prostituzione.
La famiglia dei borghesi cade naturalmente col cessare di questo suo complemento, e scompaiono entrambi collo scomparire del capitale.
Ci rimproverate di voler abolire lo sfruttamento dei fanciulli da parte dei loro genitori? Confessiamo questo delitto.
Ma, soggiungete, col sostituire l’educazione sociale alla domestica, si sopprimono i legami più cari.
E la vostra educazione non è anch’essa determinata dalla società, dai rapporti sociali in mezzo ai quali educate, dall’intervento diretto o indiretto della società, mediante la scuola, ecc.? Non sono i comunisti che inventano l’influenza della società sopra l’educazione; essi ne cambiano solo il carattere, la strappano all’influenza della classe dominante.
La fraseologia borghese sulla famiglia e sull’educazione, sopra i dolci rapporti fra genitori e figliuoli diventa tanto più nauseante quanto più la grande industria spezza ogni legame di famiglia nel proletariato e fa dei fanciulli altrettanti articoli di commercio e strumenti di lavoro.
- Ma voi comunisti volete la comunione delle donne
- ci grida in coro tutta la borghesia. Il borghese vede in sua moglie un semplice strumento di produzione. Sente dire che gli strumenti di produzione saranno sfruttati in comune e naturalmente pensa che la stessa sorte colpirà anche le donne.
Non imagina che si tratta appunto di fare della donna qualcosa più di un semplice strumento di produzione.
Nulla del resto è più ridicolo del pudico sgomento dei nostri borghesi per la pretesa comunanza delle donne nel regime comunista. I comunisti non hanno bisogno di introdurre la comunanza delle donne; essa è quasi sempre esistita.
I nostri borghesi non contenti di avere a discrezione le mogli e le figlie dei loro proletarî, per tacere della prostituzione ufficiale, trovano inoltre gran piacere nel sedursi scambievolmente le mogli.
Il matrimonio borghese è davvero la comunanza delle mogli. Tutt’al più si potrebbe rimproverare ai comunisti di voler sostituire, alla comunanza di donne ipocritamente celata, quella ufficiale e palese; ma si comprende anche che coll’abolizione degli attuali rapporti di produzione scompare la comunanza delle donne che ne risulta, e quindi la prostituzione ufficiale o meno.
Si rimprovera inoltre ai comunisti di voler distruggere la patria e la nazionalità.
Gli operai non hanno patria. Non si può toglier loro ciò che non hanno. Quando il proletariato può
conquistarsi il dominio politico, elevarsi a classe nazionale, costituirsi in nazione, anch’esso è nazionale, benchè non lo sia nel senso borghese.
Le separazioni e gli antagonismi dei popoli scompaiono già rapidamente collo sviluppo della borghesia, colla libertà di commercio, col mercato mondiale, coll’uniformità della produzione industriale e i rapporti corrispondenti.
Il dominio del proletariato li farà scomparire ancor più. L’unione delle forze, almeno per i paesi civili, è una delle prime condizioni della liberazione del proletariato. A misura che verrà tolto lo sfruttamento di un individuo sopra un altro, scomparirà lo sfruttamento di
una nazione sulle altre.
Collo sparire dei contrasti delle classi all’interno spariscono del pari le ostilità internazionali.
Le accuse sollevate generalmente contro il comunismo sotto aspetti religiosi, filosofici e ideologici non meritano minuto esame.
Ci vuoi forse molta perspicacia per capire che, cambiando i rapporti di vita e le circostanze sociali, cioè la essenza della società umana, anche gli uomini cambiano i concetti, le considerazioni, le nozioni, insomma la coscienza?
Che cosa dimostra la storia delle idee, se non il plasmarsi della produzione spirituale sulla materiale? Le idee dominanti di ogni epoca furono sempre quelle della classe dominante.
Si parla di idee che rivoluzionano tutta una società;
ma con ciò si esprime soltanto questo fatto: che in seno alla vecchia società si sono formati gli elementi di una società nuova; che, dissolvendosi gli antichi rapporti, si dissolvono di pari passo le vecchie idee.
Quando il mondo antico tramontava, il cristianesimo vinse le antiche religioni. Quando le idee cristiane, nel
XVIII secolo, soggiacquero alla scienza, la società feudale combatteva l’estrema lotta colla borghesia, allora rivoluzionaria.
La libertà di coscienza e di religione non furono che l’espressione della libera concorrenza nel campo del sapere.
Senonchè si dirà: – le idee religiose, morali, filosofiche, politiche, giuridiche, ecc., si modificarono certamente durante l’evoluzione storica; ma la religione, la morale, la filosofia, la politica, il diritto sopravvissero a questi mutamenti.
V’hanno inoltre verità eterne, come la libertà, la giustizia, ecc., comuni ad ogni forma sociale. Ora il comunismo abolisce le verità eterne, abolisce la religione, la morale invece di riformarle, e contraddice quindi allo sviluppo storico finora osservato.
A che si riduce simile accusa? La storia della società finora registra lotte di classe con aspetti diversi secondo le epoche.
Qualunque forma esso abbia assunto, lo sfruttamento di una parte della società sull’altra parte è un fatto comune a tutti i secoli passati. Nessuna meraviglia perciò che la coscienza sociale di ogni secolo, malgrado le sue
varietà e diversità, persista ad aggirarsi in certe forme comuni, forme di coscienza che si dissolvono soltanto colla completa sparizione dell’antagonismo di classe.
La rivoluzione comunista è la rottura più radicale coi superstiti rapporti di proprietà; perciò non è strano che nel suo sviluppo venga a urtare radicalmente anche le idee sopravviventi.
Ma lasciamo le obbiezioni della borghesia contro il comunismo.
Vedemmo già sopra che il primo passo della rivoluzione operaia è il costituirsi del proletariato in classe dominatrice, è il trionfo della democrazia.
Il proletariato profitterà del suo dominio politico per togliere a mano a mano alla borghesia ogni capitale, per accentrare tutti gli strumenti di produzione in mano allo Stato, ossia al proletariato stesso organizzato come classe dominante, e per accrescere il più rapidamente possibile la massa delle forze produttive.
Naturalmente ciò non può accadere che mediante un dispotico intervento nel diritto di proprietà e nei rapporti della produzione borghese, vale a dire con misure che economicamente appaiono insufficienti e insostenibili, ma che nel corso del movimento si presentano come inevitabili per trasformare l’intero sistema di produzione.
Naturalmente codeste misure saranno diverse secondo i paesi.
Per i più progrediti potranno, in generale, applicarsi le
seguenti:6
- Espropriazione della proprietà fondiaria e impiego della rendita per le spese dello Stato.
- Forte imposta progressiva.
- Abolizione del diritto di successione.
- Confisca della proprietà degli emigranti e dei ribelli.
- Accentramento del credito nelle mani dello Stato, per mezzo di una Banca nazionale con capitale dello Stato e monopolio esclusivo.
- Accentramento dei mezzi di trasporto nelle mani dello Stato.
- Aumento delle fabbriche nazionali, degli strumenti di produzione, dissodamento e miglioramento dei terreni secondo un piano comune.
- Lavoro obbligatorio uguale per tutti, fondazione di eserciti industriali, specialmente per l’agricoltura.
- Combinazione del lavoro agricolo e industriale; misure per togliere gradatamente le differenze fra città e campagna.
- Educazione pubblica e gratuita di tutti i fanciulli. Abolizione dell’attuale lavoro dei fanciulli nelle fabbriche. Combinazione dell’educazione colla produzione materiale, ecc.
Quando, nel corso dell’evoluzione, saranno sparite le differenze di classe e ogni produzione sarà accentrata in mano degli individui associati, il potere pubblico
6 Circa il valore da attribuirsi oggi a queste proposte, veggasi la prima delle prefazioni alle edizioni precedenti.
perderà il carattere politico. Il potere politico nel suo vero senso è la forza organizzata di una classe per l’oppressione di un’altra. Quando il proletariato, organizzato necessariamente in classe nella sua lotta contro la borghesia, diventerà con una rivoluzione la classe dominante e come tale abolirà violentemente i vecchi rapporti di produzione borghese, toglierà altresì di mezzo insieme a questi le condizioni degli antagonismi di classe, e quindi anche il proprio dominio di classe.
Al posto della vecchia società borghese divisa in classi cozzanti fra loro, subentra un’associazione, nella quale il libero sviluppo di ciascuno è la condizione per il libero sviluppo di tutti.
III.
Letteratura socialista e comunista.
- ° – IL SOCIALISMO REAZIONARIO.
a) Il socialismo feudale. – L’aristocrazia francese ed inglese fu chiamata dalla sua condizione storica a scagliare libelli contro la moderna società borghese. Nella rivoluzione francese del luglio 1830 e nell’agitazione per la riforma inglese essa era stata abbattuta ancora una volta dai nuovi venuti ch’essa odiava. Non era più il caso di una seria lotta politica: le restò la lotta nel campo letterario. Ma anche in questo il vecchio frasario della restaurazione era diventato impossibile. Per guadagnar simpatie l’aristocrazia doveva trascurare in apparenza i propri interessi e formulare contro la borghesia un atto d’accusa in favore degli operai sfruttati. Si: prendeva così la soddisfazione di satireggiare i suoi nuovi dominatori o sussurrar loro all’orecchio profezie di sciagure più o meno gravi.
In tal modo sorse quel socialismo feudale, mezzo elegia e mezzo pasquinata, un po’ eco del passato e un po’ minaccia del futuro, che spesso ferì al cuore la borghesia col giudizio briosamente amaro e feroce, ma che volse al comico per la assoluta incapacità di comprendere lo svolgimento della storia moderna.
Questi scrittori sventolavano come vessillo proletario la bisaccia del mendicante, per tirarsi dietro il popolo.
Ma appena il popolo li seguiva, tosto vedeva sulle loro schiene i blasoni feudali nascosti, e si sbandava con risate irriverenti.
Alcuni legittimisti francesi e la Giovine Inghilterra riuscirono assai bene in questa commedia.
Quando i feudali affermano che il loro modo di sfruttamento era diverso dal borghese, dimenticano che esso avveniva fra circostanze e in condizioni affatto diverse e ornai tramontate. Quando soggiungono che sotto il loro dominio non esisteva il proletariato, dimenticano che il necessario rampollo del loro ordinamento sociale fu la borghesia moderna.
Del resto sanno così poco dissimulare il carattere reazionario delle loro critiche, che il loro massimo capo d’accusa contro la borghesia è d’aver lasciato svilupparsi durante il suo regime una classe che minerà tutti i vecchi ordinamenti sociali. Le rimproverano di creare, non già un proletariato qualunque, ma un proletariato rivoluzionario.
Nella politica pratica quindi essi partecipano a tutte le misure coercitive contro la classe operaia: e nella vita comune si adattano, malgrado il loro gonfio frasario, a cogliere anch’essi i frutti d’oro e a barattare la fedeltà, l’amore e l’onore col commercio della lana, delle barbabietole e degli spiriti.
Siccome il prete andò sempre d’accordo coi feudali, così il socialismo clericale accompagna il socialismo feudale.
È facilissimo dare all’ascetismo cristiano una
versione socialista. Il cristianesimo non ha forse inveito contro la proprietà privata, contro il matrimonio, contro lo Stato? Non ha predicato la beneficenza, la mendicità, il celibato, la mortificazione della carne, la vita claustrale? Il socialismo cristiano è l’acqua santa con cui il prete benedice il dispetto degli aristocratici.
b) Il socialismo piccolo-borghese. – L’aristocrazia feudale non è la sola classe che, rovesciata dalla borghesia, intisichì e morì nella moderna società borghese. Il borghigiano medioevale e il piccolo ceto rustico furono i precursori della borghesia moderna. Nei paesi ove il commercio e l’industria sono meno sviluppati, cotesta classe vegeta ancora accanto allo svilupparsi della borghesia.
Nei paesi dove la civiltà moderna si è sviluppata, si è formata una nuova piccola borghesia che oscilla tra il proletariato e la borghesia e che si va sempre ricostituendo come parte complementare della società borghese; ma i suoi componenti, continuamente ricacciati nel proletariato per effetto della concorrenza, vedono avvicinarsi il tempo in cui la grande industria farà sparire il loro ceto dalla società, e lo sostituirà con degli ispettori e degli agenti nel commercio, nella manifattura e nell’agricoltura.
In paesi come la Francia, dove la classe rurale forma più di metà della popolazione, era naturale che gli scrittori sorti contro la borghesia in favore del proletariato, nelle loro critiche del regime borghese,
assumessero i modi di vedere della piccola borghesia e della piccola agricoltura e concepissero il partito dei lavoratori dal punto di vista piccolo borghese.
Nacque così il socialismo piccolo-borghese.
Sismondi è il capo di questa letteratura, non soltanto per la Francia, ma anche per l’Inghilterra.
Questo socialismo analizzò molto acutamente le contraddizioni esistenti nei moderni rapporti di produzione. Esso denudò gli ipocriti eufemismi degli economisti, e dimostrò in modo incontestabile gli effetti deleterî delle macchine e della divisione del lavoro, la concentrazione dei capitali e delle proprietà fondiarie, la sovrapproduzione, le crisi, il necessario scomparire del piccolo ceto borghese e campagnuolo, e la miseria del proletariato, l’anarchia nella produzione, la stridente disparità nella distribuzione della ricchezza, le guerre di sterminio industriale fra le nazioni, il perdersi degli antichi costumi, della vecchia famiglia e della vecchia nazionalità.
In fondo questo socialismo o vuole ristabilire coi vecchi mezzi di produzione, di scambio e coi vecchi rapporti di proprietà anche la società antica, o vuole imprigionare di nuovo gli odierni mezzi di produzione e di scambio nel vecchio regime della proprietà ch’essi hanno distrutto e che dovevano distruggere. In ambo i casi è socialismo reazionario e utopistico.
Le corporazioni nella manifattura e il regime patriarcale nell’agricoltura: ecco la sua ultima parola.
Nel loro ultimo stadio queste aspirazioni finiscono in
uno sterile miagolio.
c) Il socialismo tedesco o il “vero” socialismo. – La letteratura socialista e comunista della Francia, nata sotto la pressione di una borghesia dominatrice ed espressione letteraria della lotta contro questo dominio, fu importata in Germania quando la borghesia cominciava appunto la sua lotta contro l’assolutismo feudale.
I filosofi, i semifilosofi e i begli spiriti tedeschi s’impadronirono avidamente di questa letteratura e dimenticarono che cogli scritti francesi non passavano in Germania le condizioni della vita francese. Nell’ambiente tedesco la letteratura francese perdette ogni significato pratico e immediato, e assunse un aspetto puramente letterario. Parve una oziosa speculazione sopra “la realizzazione dell’umana essenza”. Così pei filosofi tedeschi del secolo XVIII le rivendicazioni della prima rivoluzione francese furono semplicemente rivendicazioni della “ragion pratica” in generale, e le affermazioni della borghesia francese rivoluzionaria significavano per essi le leggi della volontà pura, quale deve essere, della genuina volontà umana.
I letterati tedeschi limitarono tutto il lavoro a metter d’accordo le loro vecchie idee filosofiche colle idee francesi, o piuttosto ad assimilarsi le idee francesi dal loro punto di vista filosofico.
Questa assimilazione accadde nello stesso modo con
cui è assimilata generalmente una lingua straniera: colla traduzione.
È noto che i manoscritti monastici, scombiccherati sulle opere classiche del paganesimo, decantavano le insipide storie di santi cattolici. I letterati tedeschi fecero l’opposto colla profana letteratura francese. Scrissero i loro non-sensi filosofici dietro l’originale francese. Per esempio parafrasavano la critica francese dei rapporti monetarî colla frase “Abdicazione dell’essenza umana”, e la critica francese dello Stato borghese coll'”Abolizione del dominio dell’universale astratto”, ecc.
La sostituzione di questa fraseologia filosofica agli svolgimenti del pensiero francese fu da essi battezzata
“Filosofia del fatto, Vero socialismo, Scienza tedesca del socialismo, Fondamenti filosofici del socialismo”, ecc.
La letteratura francese socialista-comunista venne per ciò letteralmente castrata.
E siccome in mano ai tedeschi cessò di esprimere la lotta di una classe contro un’altra, così i letterati tedeschi credettero di correggere la “unilateralità francese” perchè, invece di bisogni veri, difendevano la verità, e invece degli interessi dei proletarî, quelli dell’essere umano, dell’uomo in generale, che non è di nessuna classe, che non appartiene neppure all’azione, ma al cielo nebbioso delle fantasie filosofiche.
Questo socialismo tedesco, che così seriamente e solennemente fece i suoi goffi esercizi scolastici e strombettò come i saltimbanchi, perdette a poco a poco
la sua innocenza pedantesca.
Il moto liberale, la lotta della borghesia tedesca, massime la prussiana, contro i sostenitori del feudalismo e del regno assoluto, si fecero più seri.
Al “vero” socialismo si offrì questa volta il destro di contrapporre al moto politico le riforme socialiste, di gettare gli ultimi insulti contro il liberalismo, contro lo Stato rappresentativo, contro la concorrenza borghese, la libertà di stampa borghese, il diritto, la libertà e l’uguaglianza borghese, di predicare alle masse che non avevano niente da guadagnare nell’agitazione, ma piuttosto tutto da perdere. Il socialismo tedesco dimenticò proprio allora che la critica francese, di cui esso non fu che la vana eco, attaccava una società borghese avente già le sue condizioni materiali di vita e la sua costituzione politica, e che tutte queste eran riforme che si trattava prima di ottenere in Germania.
Fece quindi il giuoco dei governi tedeschi assoluti, dei preti, dei maestri di scuola, dei gentiluomini di campagna e dei burocratici, come ottimo spauracchio contro l’insorgente e minacciante borghesia.
Fu il delizioso complemento delle sferzate e delle fucilate con cui i detti governi prepararono la sollevazione operaia.
Siccome il “vero” socialismo si presentò come un’arme in mano dei governi contro la borghesia tedesca, così esso immediatamente si risolvette nella difesa di un interesse reazionario, quello dei piccoli borghesi.
In Germania la piccola borghesia, trasmessa dal secolo XVI e sempre d’allora in poi rinascente in diverse forme, costituì la base sociale delle condizioni del paese.
La sua conservazione è in Germania la conservazione dello statu quo. Essa teme dal dominio industriale e politico della borghesia una sicura rovina, da un lato pel concentramento del capitale, dall’altro pel sorgere di un proletariato rivoluzionario. Il “vero” socialismo le sembrò ottimo spediente per prendere due piccioni a una fava, e si diffuse come una vera epidemia.
Il pomposo manto di questo socialismo, ordito su una trama speculativa, ricamato di fiori oratorî e stillante dolce rugiada sentimentale, nelle pieghe del quale i socialisti tedeschi nascondevano un paio delle loro stecchite “verità eterne”, non fece che aumentare lo spaccio della loro mercanzia presso codesta specie di avventori.
Dal canto suo il socialismo tedesco riconobbe sempre meglio che la sua missione era quella di rimanere l’ampolloso rappresentante di cotesta minuta borghesia.
Esso proclamò che la nazione tedesca è la nazione normale e il piccolo borghese tedesco l’uomo normale. Diede a ogni bassezza di costui un significato nascosto, sublime, socialistico, in perfetta antitesi colla realtà.
Giunse all’ultima conseguenza scagliandosi direttamente contro le tendenze vandaliche del comunismo, e proclamando la propria imparziale elevatezza sopra ogni lotta di classe. Salvo pochissime eccezioni, tutti gli scritti pretesi socialisti e comunisti
che circolano in Germania appartengono a questa snervante e sucida letteratura.7
- ° – IL SOCIALISMO CONSERVATORE O BORGHESE.
Una parte della borghesia vorrebbe migliorare le condizioni sociali per assicurare l’esistenza della società borghese.
Ne fanno parte gli economisti, i filantropi, gli umanitari, gli zelanti del miglioramento delle condizioni delle classi operaie, gli organizzatori di beneficenze, gli zoofili, i fondatori di circoli di temperanza e tutta la variopinta schiera dei riformatori da conventicola. Anche di questo socialismo borghese si crearono dei veri sistemi.
Citiamo ad esempio la Philosophie de la misère di Proudhon.
I socialisti borghesi vogliono mantenute le basi della moderna società senza le lotte e i pericoli che necessariamente ne risultano.
Vogliono la società attuale scartandone gli elementi che la mettono in rivoluzione e in dissoluzione. Vogliono la borghesia senza il proletariato. È naturale che la borghesia si figuri la società ove essa domina come la migliore di tutte. Il socialismo borghese trae da questa consolante idea un mezzo sistema o anche un
7 La bufera reazionaria del 1848 spazzò via queste scrofolose tendenze e levò la voglia ai loro rappresentanti di fare del socialismo. Il rappresentante principale e il tipo classico di cotesta scuola fu il sig. Carlo Grün.
sistema completo. Quando invita il proletariato a metterlo in pratica, a entrare nella nuova Gerusalemme, in fondo gli domanda di restare quel che è nella società presente, rinunciando al concetto odioso che se ne fa.
Un’altra forma di socialismo, meno sistematica e meno pratica, cercò di svogliare la classe operaia dai moti rivoluzionarî, dimostrando come ciò che le può giovare non sono le trasformazioni politiche, ma soltanto le trasformazioni economiche. Le quali trasformazioni non sono già per esso l’abolizione della forma di produzione borghese, la quale non può conseguirsi che coi mezzi rivoluzionarî, ma soltanto miglioramenti amministrativi compatibili con cotesta forma di produzione, che non cambiano affatto il rapporto tra capitale e lavoro salariato, e nel miglior caso diminuiscono alla borghesia le spese del suo dominio, semplificando l’economia dello Stato.
Questo socialismo borghese raggiunge la sua più esatta espressione quando diventa semplice figura retorica.
Libero commercio, a vantaggio delle classi operaie; dazi protettori, a vantaggio delle classi, operaie; carcere cellulare, a vantaggio delle classi operaie: ecco l’ultima, la sola parola seriamente pensata del socialismo borghese.
Il socialismo borghese consiste tutto nel sostenere che i borghesi sono borghesi… a vantaggio delle classi operaie.
- ° – SOCIALISMO E COMUNISMO CRITICO-UTOPISTICO.
Non parliamo qui della letteratura, che in tutte le grandi rivoluzioni moderne formulò le pretese del proletariato (scritti di Babuf, ecc.).
I primi tentativi fatti dal proletariato, per far prevalere i propri interessi di classe, in un tempo di sovreccitazione generale, quando la società feudale crollava, dovettero fatalmente fallire, sia per il difetto di sviluppo del proletariato, sia per la mancanza delle condizioni materiali necessarie alla sua emancipazione, le quali non possono essere che il prodotto dell’epoca borghese. La letteratura rivoluzionaria, che accompagnò i primi moti del proletariato, è nel suo intimo necessariamente reazionaria. Essa insegna un ascetismo universale e una rozza uguaglianza.
I sistemi socialisti e comunisti propriamente detti, quelli di Saint-Simon, Fourier, Owen, ecc., fanno capolino nei primi indeterminati periodi della lotta fra proletariato e borghesia, come dicemmo più sopra. (Vedi Borghesi e Proletari).
Gli autori di tali sistemi rilevano bensì il contrasto fra le classi e l’azione degli elementi dissolventi nella stessa società dominante, ma non scorgono nel proletariato nessuna funzione storica speciale, nessun moto politico suo proprio.
Siccome gli antagonismi di classe si sviluppano di pari passo coll’industria, questi socialisti, non trovando sufficienti condizioni materiali per l’emancipazione del
proletariato, vanno in cerca, per crearle, di una scienza sociale e di date leggi sociali.
All’azione sociale sostituiscono la loro azione inventiva personale, alle condizioni storiche sostituiscono l’emancipazione fantastica, allo spontaneo e graduale organizzarsi del proletariato in classe, una fittizia organizzazione della società. La storia universale dell’avvenire si risolve per essi in propaganda ed esecuzione dei loro piani sociali.
Sono convinti di patrocinare nei loro progetti specialmente il bene delle classi operaie come le più sofferenti. Il proletariato esiste per essi soltanto sotto questo aspetto, che è la classe che più soffre.
La forma incompleta della lotta di classe e le loro speciali condizioni di vita li inducono a credersi molto superiori a questa lotta di classi. Essi vogliono migliorare le condizioni di tutti gli individui, anche dei più favoriti. Fanno appello continuamente a tutta la società senza distinzione, benchè si volgano di preferenza alla classe dominante. Basta, secondo essi, capire il loro sistema per riconoscere che è il miglior possibile ordinamento della migliore società possibile.
Essi disapprovano quindi ogni azione politica, vale a dire rivoluzionaria, vogliono raggiungere lo scopo con mezzi pacifici, e cercano con piccoli e perciò inani esperimenti, colla potenza dell’esempio, di aprir la strada al vangelo sociale.
Il quadro fantastico di questa società futura è fatto in un tempo in cui il proletariato è ancora assai
rudimentale e perciò comprende ancora fantasticamente la propria condizione, le sue velleità di aspirazione ad una generale trasformazione della società.
Gli scritti socialisti e comunisti si fondano per altro su elementi critici. Attaccano tutte le basi della vigente società. Essi hanno perciò fornito preziosissimi materiali per educare e illuminare gli operai. Le loro affermazioni positive sopra la società futura, per esempio, l’abolizione dei contrasti fra città e campagna, della famiglia, del guadagno privato, della mercede, l’annunzio dell’armonia sociale, il mutamento dello Stato in semplice amministrazione della produzione – tutte queste affermazioni esprimono soltanto il cessare dei contrasti di classe che cominciano appunto allora e che essi conoscono appena rudimentalmente. Queste affermazioni hanno dunque un senso esclusivamente utopistico.
L’importanza del socialismo e del comunismo critico- utopistico sta in ragione inversa coll’evoluzione storica. A misura che la lotta di classe si sviluppa e prende forma, la fantastica superiorità sopra la lotta reale, il combattimento utopistico, perdono ogni valore pratico, ogni autorità teorica. Se anche i promotori di tali sistemi furono per molti aspetti rivoluzionarî, i loro scolari si schierano sempre colle sette reazionarie, e contrappongono al progressivo sviluppo storico del proletariato i vecchi concetti del maestro. Cercano perciò di soffocare la lotta di classe e di appianare i contrasti; sognano sempre la prova sperimentale delle
loro teorie utopistiche, fondazione di singoli falansteri, colonie all’interno, piccole Icarie8 – edizioni in dodicesimo della nuova Gerusalemme – e fanno appello alla filantropia dei cuori e dei borsellini borghesi per la costruzione di tali castelli aerei. A poco a poco cadono nella categoria dei socialisti reazionarî o conservatori di cui già parlammo e si distinguono da quelli soltanto per una sistematica pedanteria, per una fede fanatica e superstiziosa nella virtù meravigliosa della loro scienza sociale.
Essi osteggiano perciò con amarezza ogni movimento politico degli operai, il quale non può partire che da una cieca incredulità al nuovo evangelo.
Gli Owenisti in Inghilterra reagiscono contro i Cartisti; i Fourieristi in Francia contro i Riformisti.
8 Colonie all’interno (home-colonien) chiama Owen le sue comunistiche società-modello. Falanstero era il nome dei palazzi sociali ideati da Fourier. Si chiamò Icaria il paese fantastico il cui congegno comunistico fu schizzato da Cabet.
IV.
Atteggiamento dei Comunisti
di fronte ai varî partiti d’opposizione.
Nella seconda parte si parla dei rapporti che hanno i comunisti coi partiti operai già indipendentemente costituiti, e quindi anche coi Cartisti in Inghilterra e coi Riformisti agrarii nell’America del Nord.
I comunisti lottano bensì per raggiungere scopi immediati nell’interesse delle classi lavoratrici, ma nel moto presente rappresentano eziandio l’avvenire del movimento. In Francia i comunisti si accostano al partito socialista democratico9 contro la borghesia conservatrice e radicale, senza rinunciare perciò all’esame critico delle frasi e delle illusioni derivanti dalla tradizione rivoluzionaria.
In Svizzera spalleggiano i radicali, senza disconoscere che questo partito è composto di elementi contradditorî, parte di socialisti democratici nel senso francese, parte di borghesi radicali.
Fra i Polacchi i comunisti appoggiano il partito che mette come condizione del riscatto nazionale la rivoluzione agraria, lo stesso partito che suscitò l’insurrezione di Cracovia del 1846.
In Germania il partito comunista lotta insieme colla
9 Quello che allora in Francia si chiamava partito socialista democratico era rappresentato in politica da Ledru-Rollin e in letteratura da Louis Blanc; lontano, dunque, le mille miglia dall’odierna democrazia-socialista tedesca.
borghesia, ogni qualvolta questa combatte per un principio rivoluzionario contro la monarchia assoluta, contro l’antica proprietà feudale e contro la piccola borghesia.
Esso però non cessa un istante di sviluppare fra i lavo lavoratori la più chiara coscienza dell’antagonismo fra borghesia e proletariato, acciocchè i lavoratori tedeschi si servano delle condizioni sociali e politiche introdotte dal dominio borghese come di altrettante armi contro la borghesia medesima, e al cadere delle classi reazionarie in Germania segua subito la lotta contro la borghesia stessa.
Sulla Germania rivolgono i comunisti specialmente la loro attenzione, perchè la Germania è alla vigilia di una rivoluzione borghese, la quale si compie in condizioni di civiltà generale europea più avanzate e con un proletariato molto più sviluppato, che non avessero l’Inghilterra nel secolo XVII e la Francia nel XVIII; per cui la rivoluzione borghese tedesca non può essere che l’immediato prologo di una rivoluzione proletaria.
In una parola i comunisti appoggiano in generale ogni moto rivoluzionario contro le condizioni sociali e politiche esistenti.
In tutti questi moti essi mettono avanti sempre la questione della proprietà, abbia essa raggiunto una forma più o meno sviluppata, come la questione fondamentale del movimento.
I comunisti finalmente lavorano all’unione e all’intesa dei partiti democratici d’ogni paese.
I comunisti sdegnano di nascondere i loro principî e i loro scopi. Dichiarano apertamente che il loro scopo non potrà esser raggiunto che colla caduta violenta di tutti gli ordinamenti sociali finora esistiti. Le classi dominanti possono tremare davanti ad una rivoluzione comunista. I proletarî non hanno nulla da perdere in essa fuorchè le loro catene. Hanno un mondo da guadagnare.
Proletarî di tutti i paesi, unitevi!
-------- VERSIONE COMPLETAeseguita sulla 5.a edizione tedesca (Berlino 1891)
DA
POMPEO BETTINI